di Padre Alberto Maggi
Un cammino in appena dieci passi per entrare nel cuore del messaggio cristiano, mostrando come la parola misericordia ne sia l’asse portante: è questo il grande compito che si è assunto Roberto Mancini, con il libro “Il senso della misericordia”. Padre Alberto Maggi, nella sua introduzione, ci mostra il valore di questo libro e la sua forza rivoluzionaria.
Punto centrale del Vangelo, quindi della vita del credente, il tema della misericordia dovrebbe essere più che conosciuto, in realtà, leggendo queste pagine, si scopre che non è così. Travisamenti, errori, interessi, opportunità, diplomazie, convenienze, manipolazioni, son tutti detriti che hanno come seppellito il Vangelo e offuscato la misericordia. Con il suo lavoro l’autore aiuta il lettore a togliere pazientemente queste scorie: a leggere queste pagine ci si sente come Saulo di Tarso quando “gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista” (At 9,18). Il lavoro di Roberto Mancini non è fine a se stesso, è in gioco la scoperta della felicità indistruttibile, del disegno d’amore del Padre su ogni creatura. L’autore non scopre la Misericordia, semplicemente aiuta a eliminare quegli impedimenti religiosi, culturali, strutturali, ambientali, psichici che impedivano di vederne lo splendore e, di fatto, l’avevano relegata a una pia virtù da parte dei devoti o a una supplica alla divinità, riducendo la misericordia a un ripetuto insistente kyrieleison, cristeleison, “come uno schiavo che si sente in colpa verso il padrone”.

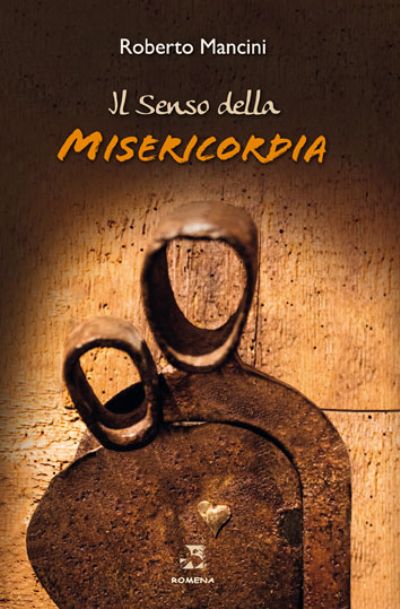
Leggendo queste pagine si comprende anche meglio l’azione intrapresa da papa Francesco che ha fatto della Misericordia la strada maestra del suo pontificato, cammino tanto nuovo quanto antico perché si richiama direttamente alla missione di Gesù. Papa Francesco, sulle orme di Gesù Cristo, non intende portare gli uomini verso Dio. I leader religiosi che perseguivano tale ambizioso obiettivo hanno dovuto constatare il loro fallimento. Perché se si vuole portare gli uomini verso Dio, il cammino è quello dell’osservanza delle leggi divine e, inevitabilmente, alcuni restano indietro e altri rimangono addirittura esclusi. Per questo Gesù ha cambiato la direzione di marcia dell’umanità: non più portare gli uomini a Dio, ma Dio agli uomini e, quando si porta Dio agli uomini, l’unico linguaggio non è quello della Legge, ma quello della misericordia (“La Legge fu data per mezzo di Mos., la grazia e la verit. vennero per mezzo di Ges. Cristo”, Gv 1,17).
Attraverso la Misericordia nessuno rimane escluso da questo Dio che Gesù fa conoscere come Padre, traghettando gli uomini dalla religione (quel che il credente deve fare per Dio) alla fede (quel che il Padre fa per i figli). Il passaggio dalla religione alla fede è indispensabile per accogliere un Dio che si offre ai suoi figli, un Signore che già attraverso i profeti aveva fatto sentire il suo imperativo: “Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio pi. degli olocausti” (Os 6,6; Mt 9,13; 12,7).
Come mai, s’interroga Mancini, queste parole non furono prese sul serio? La misericordia fa difficoltà a essere accolta perché l’uomo è più incline al sacrificio, sicché mentre “L’Altissimo si china sulla creatura a dire «non voglio sacrificio», il credente risponde, come se niente fosse, «fa’ di me un sacrificio vivente a te gradito». E il tragico risultato è stato che storicamente ci siamo mossi come se Dio ci avesse chiesto: «sacrificio io voglio e non misericordia»”. Liberarsi da questa mentalità è molto difficile per quelli che l’autore definisce i “nativi religiosi”, quasi che l’idea del sacrificio sia scritta nel loro DNA. Costoro sono radicati nella spiritualità religiosa del merito (l’uomo deve meritare con i suoi sforzi l’amore di Dio) e per questo sono chiusi e refrattari alla spiritualità evangelica del dono, l’amore del Padre concesso non come un premio per i meriti dell’uomo, ma quale dono per i suoi bisogni (Lc 18,9-14).
Per Mancini la religione non è altro che il surrogato della filialità, quel che impedisce a Dio di essere Padre, relegandolo al rango di massima suprema Potenza. Lugubre eredità della spiritualità religiosa, è la visione della vita come una pena da scontare, nella convinzione che la felicità non sia di questo mondo, in piena contraddizione con la Buona notizia di Gesù, che lascia ai suoi la pienezza stessa della sua gioia (Gv 17,13). È stato arduo per Gesù far comprendere che suo Padre non è il dio della religione, quello lontano dagli uomini, ma un Dio che chiede a ogni uomo il permesso di fondersi con lui, per dilatare il suo cuore e renderlo così l’unico vero santuario dal quale si irradia il suo amore e la sua misericordia (Gv 14,23). Questa accoglienza di Dio nel cuore dell’uomo, con la quale il Creatore stabilisce una comunione con le creature, viene formulata da Mancini attraverso l’ardita immagine della filialità, un Dio che nell’uomo si fa figlio. Un Dio che non manifesta la sua presenza quando l’uomo alza le braccia al cielo per accoglierlo, ma quando le abbassa per donarlo, nel servire chi ha bisogno. Il distintivo del credente non sono le mani giunte, ma le mani sempre pronte ad aiutare. Il misericordioso non è colui che ricorda il bisognoso nelle sue preghiere, ma chi è riconoscibile per essere sempre disponibile a dare una mano.
La Misericordia non è una delle espressioni dell’Amore, del perdono di Dio, ma è Dio stesso, è l’Amore stesso, o come ama ripetere papa Francesco, “il nome di Dio. Misericordia”. Pertanto scoprire la Misericordia è riconoscere chi è Dio. Quando si arriva alle ultime righe di questo prezioso libro, sgorga spontanea e riconoscente nel cuore la preghiera di Giobbe “Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto” (Gb 42,5). Si pensava di conoscere cosa fosse la misericordia, ma ci voleva Roberto Mancini per farcela vedere.
Tratto dalla rivista di Romena, n. 1/2016 Accogliere


